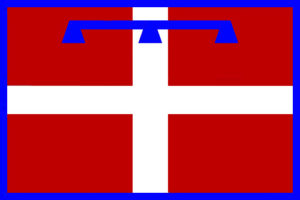Forse mai come in questi anni si è fatta così forte in me la nostalgia della cantina (così era chiamata nella montagna Condovese quelle che oggi sono osterie o vinerie), luogo dove si poteva degustare un buon bicchiere di vino. Probabilmente sto invecchiando, ma può darsi che sia divenuto semplicemente più maturo e più legato ai modelli di vita di un tempo. Anzi, dirò di più, alla civiltà di un tempo. Perché proprio di civiltà si tratta, di quella della mia gente e della mia terra, aperta da decenni a tutte le manomissioni e devastazioni. Non sono un esaltatore acritico del passato, per carità!, ma lasciatemi dire che nel nostro passato montanaro c’era e c’è ancora molto di buono, di umano, di civile convivenza.
La storia e la letteratura italiana sono sature di riferimenti alla cantina come momento fondamentale d’incontro nella vita quotidiana, così come la piazza o la chiesa, perché la cantina era il posto dove gli uomini passavano un po’ di tempo in compagnia di amici e paesani, scambiandosi racconti e opinioni, accompagnati da buon vino. La cantina di Laietto era il centro della comunità delle borgate la Vagera, Sigliodo, Arronco, Chiandone, Coindo, Pratobotrile, Camporossetto e Muni con la capacità di riunire, infondere quella gioia e convivialità tipicamente montanare.
L’oste, che dominava sovrano questo via vai di gente d’ogni posizione sociale e reputazione, aveva di conseguenza fama di persona astuta, perché sapeva soddisfare indistintamente le necessità dei suoi avventori, conciliandole al meglio con il proprio tornaconto personale. Era sempre ben informato, grazie alle chiacchiere che gli giravano attorno, spesso sconsideratamente liberate da menti piuttosto annebbiate dai fumi dell’alcool, e sapeva sempre come trarre profitto delle occasioni che gli si presentavano. Non a caso la nostra lingua è piena di espressioni proverbiali che ne testimoniano l’astuzia: si pensi al detto “fare i conti senza l’oste” o alla similitudine “come chiedere all’oste se il vino è buono” oppure “per l’oste sono tutti galantuomini purché paghino”, tutti rivelatori della capacità dell’oste di fare i propri interessi.
A Laietto c’erano negli anni successivi alla II° guerra mondiale due cantine: quella di Mento e Luigina (locanda Belvedere) e l’altra di Gildo (osteria Pettigiani), la prima con rivendita tabacchi ad inizio borgata e la seconda verso la fine. La più antica era quella di Gildo il quale produceva vino da una sua vigna ma ne acquistava anche dal piano facendo trasportare le botti a dorso di mulo. In quel periodo capitava sovente di incontrare Gildo che saliva per la mulattiera da Condove con la mula carica di due brente (misura piemontese eguale a 50 litri) di vino oppure vederlo con la mula salire al Santuario del Collombardo nel giorno della festa (2 agosto) dove curava la cantina per i pellegrini. Qualche volta da Gildo mio nonno “Batita dou vrian” (Pautasso Battista) ridendo sotto i baffi applicava un antico segreto popolano per capire se il vino era stato mischiato con acqua: prendeva il nocciolo di una pesca ben secco, lo tagliava a metà e lo immergeva nel vino: se c’era acqua andava a fondo e tornava su, se non c’era acqua stava sul fondo. Antichissima nella valle del Gravio la coltivazione della vite, che ai primi del 1900 si spingeva fino ai 1.100÷1.200 metri di altitudine, soprattutto nella varietà rustica del vitigno Becuèt, ma anche Avanà, “Carcheirun” o Carcairone, Grisa, Barbera e queste erano estese in particolare nella fascia ben esposta della Villa di Mocchie, Gazzina, Bertolere, Borlera, Bonaudi, Pralesio e, sotto Frassinere, in località Roceja dove si trovavano le vigne che traevano vantaggio dalla buona esposizione e dall’azione riscaldante delle rocce che riflettono i caldi raggi solari. Il Becuèt è un vitigno in grado di fornire un prodotto molto gradito agli assaggiatori e di buone caratteristiche compositive, di colore, intenso e caratteristico che lo rende ideale sia per una produzione di vini freschi, fragranti e profumati che si esprimono al meglio in gioventù che per il taglio con l’Avanà.
Quando si entrava da Gildo un qualcosa di misterioso, ci spingeva ad accomodarci sulle comode panche, dove un fuoco sempre acceso infondeva la voglia di stare insieme magari assaporando un bollente brulé nelle giornate fredde o un bicchiere di vino. Nella cantina si incontrava gli altri,si faceva una partita di briscola o di tressette, si veniva a sapere le novità della borgata, di situazioni economiche proprie e di terzi, allegre e poco allegre. Davanti a un bicchiere di vino, bianco o rosso ci si sente tutti primi ministri, presidenti, papi, teste coronate (pensate al detto piemontese: “Andova a regna ‘l vin a-i regna nen ël silensi”). Le frasi colorite non contano nelle osterie e, purtroppo, volano bestemmie, le solite e altre di improvvisata fantasia. Se forestiero volevi imparare il patois (la parlata locale) o il piemontese, la migliore scuola che trovavi era la cantina. Il pittoresco e ricco linguaggio degli anziani si mescolava a quello più slavato dei giovani, che peraltro, aggiungeva termini nuovi del vivere quotidiano e del lavoro in fabbrica e ne veniva fuori una lingua tra antico e moderno, un patois mediato e robusto. Nella cantina si apprendevano casi sociali cui venire incontro e che, stando a casa, non avresti saputo. Le cantine per secoli sono state i principali luoghi di ritrovo e socializzazione degli uomini, nelle giornate festive o nella stagione invernale, quando i campi richiedevano meno lavoro e le ore di luce erano poche. Le donne invece si ritrovavano nelle case ad accudire le faccende domestiche, lasciate sole con i loro grandi problemi (bilancio famigliare, figli, ecc.), ma la cantina è anche un focolare di amicizia e di solidarietà, trovi l’allegria dello spuntino con salame e formaggi nostrani. Certamente si beve, ma tutto sta nella misura individuale di assunzione delle bevande. Stanno sparendo le grandi ubriacature che contrassegnavano certi pittoreschi personaggi paesani, beoni dal naso paonazzo. Si distinguevano, ma si distinguono tuttora: la “cioca alégra”, la “cioca anrabià” e si potrebbe aggiungere anche la “cioca cantérin-a”. Nelle cantine si giocava soprattutto a carte, a dadi o alla morra. Per le carte si usavano i mazzi piemontesi, con quattro semi: fiori, picche, cuori e quadri. I più diffusi giochi di carte erano il tressette, la briscola e la scopa.
Un modo tradizionale per stare insieme all’esterno è invece rappresentato dal gioco delle bocce (in quel periodo erano di legno), ancora praticato con passione specialmente dagli anziani ma non soltanto. Si tratta di una pratica diffusa specialmente nella Francia meridionale e in Piemonte. In montagna si giocava al libero, ossia senza un campo delimitato.
Ai nostri giorni le due cantine del Laietto non ci sono più, che cosa è cambiato dai tempi di una volta? Sicuramente la domanda, di conseguenza l’offerta. La voglia di novità, di cambiare sempre i luoghi di ritrovo e il giro di incontri, oggi in apparenza potrebbe sembrare che a nessuno importi trovare un luogo dove sentirsi come in famiglia, eppure, in questa giostra di novità e mutamenti, il fine è sempre il medesimo per tutti: eludere la solitudine e le preoccupazioni.
GIOCARE ALLA MORRA NELLA CANTINA
Nella cantina di Laietto uomini di tutte le età, raramente le donne, passavano il tempo libero, o quello che liberamente sceglievano di ritagliarsi, a bere, chiacchierare, discutere animatamente, a giocare a carte, a cantare. Quando poi gli effetti del vino cominciavano a prevalere e a scaldare gli animi, non era raro che qualcuno si alzasse e desse inizio ad una sfida al gioco della morra. Subito il locale si riempiva di suoni e rumori particolari, perché il gioco è particolarmente vivace e consiste nell’indovinare la somma dei numeri che vengono mostrati con le dita dai giocatori. Questi presentano la mano sbattendola ritmicamente sul tavolo con un numero di dita a scelta e gridando un numero compreso tra due e dieci. I numeri, gridati da entrambi i contendenti in modo simultaneo e in dialetto, sono spesso storpiati in forme colorite per renderli di più immediata e facile pronuncia. Vince il punto il giocatore che indovina (e che quindi l’ha strillata) la somma delle dita espresse in quel momento. Nel caso in cui entrambi predicano la somma esatta, il punto non viene assegnato. Il gioco finisce quando uno dei due raggiunge il punteggio deciso in precedenza. Il gioco della morra si svolge con velocità ed effetto acustico, tanto da comportare spesso indolenzimenti al braccio e la perdita della voce. L’abilità sta nel prevedere il gioco dell’avversario e nel non far comprendere il proprio, nel sovrastare l’avversario con violenza verbale e nella malizia di modificare con destrezza il proprio numero di dita all’ultimo istante. Anche la variazione delle espressioni gioca un ruolo importante prestandosi ad astuzie più o meno lecite. Nel clima dell’osteria scaldato anche da qualche bicchiere di vino, le dispute davano spesso luogo a risse, per questa ragione la morra è elencata fra i giochi proibiti nei locali pubblici, anche se spesse volte tale divieto non veniva rispettato.
IL GIOCO DEI DADI
I dadi sono strettamente associati al vino, perché attraverso il gioco si spera di vincere il necessario per una bevuta. Purtroppo spesso va male, e allora il gioco spoglia di ogni avere i malcapitati; perdendo ci si rende conto del rapido mutare del destino umano, si comprendere il volgere della ruota della Fortuna.
Chi perde rimane nudo, in perfetta evangelica povertà, ma si consola con il vino. Il vino, divinità generosa, ai suoi fedeli dona l’ebbrezza, il sollievo dagli affanni dell’esistenza: l’ubriacatura collettiva è un rito cui non ci si può sottrarre, perché l’osteria è anche il luogo dove si realizza una utopistica società in cui le barriere tra gli ordini vengono meno e tutti sono uguali.
I dadi sono piccoli oggetti di forma poliedrica, utilizzati nel contesto di diversi giochi per generare in modo casuale esiti numerici o di altro tipo. I dadi tradizionali, utilizzati dalla maggior parte dei giochi, sono cubi con le facce marcate con i numeri naturali da 1 a 6; tuttavia, giochi specifici possono fare uso di innumerevoli varianti. Per ottenere un valore casuale, si fa rotolare il dado su una superficie piana, e convenzionalmente viene preso in considerazione come “risultato” il valore che si viene a trovare sulla faccia rivolta verso l’alto quando il dado termina il proprio movimento. L’esito così ottenuto si può considerare casuale (ai fini pratici) solo se il movimento impartito inizialmente al dado è sufficiente a farlo rotolare e rimbalzare in modo complesso (e quindi imprevedibile). L’atto che impartisce il movimento iniziale deve quindi essere abbastanza deciso, e nella lingua comune viene indicato con l’espressione lanciare i dadi.
Gianni Cordola