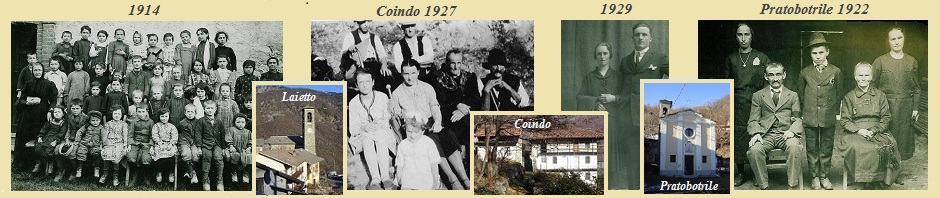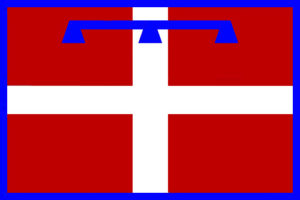La fede nel mondo rurale della montagna Condovese era profondamente radicata. Lo testimoniano le chiese e cappelle presenti in quasi tutte le borgate e gli innumerevoli piloni che punteggiano il territorio.
L’arte sacra nelle chiese e cappelle racconta la ricca storia del territorio di Condove, Mocchie e Frassinere: pale d’altare, dipinti, sculture… Non si sa più dove fissare lo sguardo. Questa ricchezza ti aspetta, quindi via alla scoperta delle cappelle di Condove. Non fanno parte di questa raccolta le Chiese parrocchiali trattate in altra parte.
Cappella della Beata Vergine di Oropa alla borgata Alotti
La cappella fu edificata nel 1826. La facciata è profilata a capanna, terminata dal timpano triangolare e conclusa agli spigoli da lesene. La copertura a due falde del tetto sporge sulla facciata a proteggere l’ingresso: un portalino sottolineato da paraste e timpano arcuato, sormontato da una finestra mistilinea e in asse è collocato il campanile “a vela”. L’aula si sviluppa a navata unica rettangolare coperta da due campate di volte a vela con abside piatta. Muratura portante di tipo misto intonacato, tinteggiato esternamente in facciata, lasciato ad intonaco al naturale sui restanti lati. Interno intonacato, tinteggiato e decorato; un tirante ligneo è posto lungo l’arco di unione delle due campate e l’apparato decorativo plastico è composto da lesene e cornice d’imposta delle volte.
Impianto decorativo pittorico pregevole raffigurante tessuti drappeggiati e vasi di fiori coevo alla data apposta sulla facciata (1826).
Cappella di San Giovanni Vincenzo alla borgata Bellafugera
La cappella è citata nella relazione sullo stato della parrocchia redatta nel 1820. Fu interamente ricostruita nel 1865 sul sito di quella più antica.
La cappella di San Giovanni Vincenzo fa parte di un piccolo nucleo a Bellafugera di Condove, ma spicca per la sua posizione dominante, costruita su una roccia. La facciata, intonacata, è decorata da quattro lesene che ne scandiscono le porzioni verticali ed è terminata da un timpano triangolare. Il tetto è a due falde con manto di copertura in lose. Un campanile “a vela” è sistemato sul muro d’ambito destro. Internamente si sviluppa secondo uno schema rettangolare, a navata unica conclusa da un’abside semicircolare. Sul fianco destro si appoggia una piccola sacrestia. Una cantoria lignea é posta sulla controfacciata. Muratura portante in pietrame, intonacato e tinteggiato esternamente in facciata, lasciato a vista sui restanti lati. Interno intonacato e tinteggiato con una cornice d’imposta delle volte e lesene che decorano le pareti. In buono stato di conservazione
Cappella di San Rocco alla borgata Bigliasco
Il più antico decreto che si conosca riguardante questa Cappella è del 29 giugno 1624 nel quale si proibiva seriamente di celebrare se prima non fosse stata chiusa da muri, cancello in legno all’entrata, provvista di pietra sacrata, candelabri e croce. Nel giugno 1643, una nuova visita fatta dal curato di Frassinere, D. Michele Valertino non trovò più inconvenienti di sorta. Una terza visita fu fatta nel 1658 e nessuna osservazione fu annotata.
Venne in parte riedificata e ingrandita nel 1761 e viene descritta dal Prevosto Pettigiani il 1785 come un quadrato con cupolino. Don Mercandini nel 1791 annota che fu espropriato un orto che la fiancheggiava a mezzodì e vi si costruì una sacrestia.
La facciata è profilata a semplice capanna, coperta da un tetto a due falde che si protendono a proteggere l’ingresso; questo è sormontato da un oculo circolare e affiancato da due piccole finestre. Il campanile “a vela” è posto in asse. L’edificio si compone di un’aula a pianta rettangolare, terminata da abside piatta. Sul lato destro, all’altezza del presbiterio, si apre una cappella. Il presbiterio è coperto da una cupola molto ribassata, appoggiata su pennacchi, che all’esterno non è evidenziata ma è contenuta nel tetto a doppio spiovente, con manto di copertura in lose, lievemente rialzato rispetto a quello che copre la navata. Muratura portante di tipo misto intonacato, tinteggiato in facciata e lasciato al naturale sui restanti lati; intonacato e tinteggiato internamente.
Cappella dei Santi Giacomo e Anna alla borgata Bonaudi
Cappella di cui non esistono tracce o resti e non citata nelle più antiche visite pastorali del 1509, del 1612, 1624 e altre. Ma nelle aggiunte che Don Gaspare Mercandini (parroco di Mocchie dal 1791 al 1806) fece alla relazione sullo stato della parrocchia redatta dal suo predecessore Don Michele Antonio Pettigiani nel 1785 e riprese da Mons. Giuseppe Antonio Vinassa, risulta che la cappella più antica della parrocchia di Mocchie è quella di Bonaudi dedicata a San Giacomo e Sant’Anna, probabilmente distrutta da movimenti franosi che avevano interessato la borgata in tempi antichi, e sorgeva probabilmente nella località detta “la tsapèla” appena fuori dell’abitato lungo la mulattiera che va a Sigliodo. Pur senza cappella per diversi anni si è comunque celebrata la messa e festeggiato la ricorrenza.
Cappella di San Martino alla borgata Camporossetto
Della Cappella esistente fuori dell’abitato e dedicata a San Martino non ci sono memorie per la sua edificazione, ma viene citata nel testamento di Martin Francesco del 1616 con un lascito per celebrarvi una messa ogni mese. È poi descritta in una visita del Vicario Abbaziale di San Giusto Vignale del 29 giugno 1624 in grave stato di degrado, per cui si può ipotizzarne la costruzione nel secolo precedente. In una successiva visita del vicario Barverio nel 1643 risulta che la Cappella è in buone condizioni come anche nella visita del 1658. Lavori di ampliamento sono stati effettuati nel 1770. Il parroco di Mocchie in una relazione del 1785 sullo stato della parrocchia scrive che la Cappella di San Martino è stata ingrandita senza dare ulteriori particolari. È probabile che nell’anno 1892 ci siano state altre importanti modifiche portando la Cappella allo stato attuale.
Lo schema planimetrico è a navata unica con abside semicircolare coperta da calotta nervata. La copertura dell’aula è a botte con unghie. Muratura portante di tipo misto intonacata, tinteggiata esternamente sulla facciata principale e senza colore sulle altre. Interno intonacato e tinteggiato. Un’alta cornice corre lungo tutte le pareti a sottolineare l’imposta della volta.
Cappella della Madonna delle Grazie nel Castrum Capriarum
La cappella della Madonna delle Grazie nel castello detto erroneamente del Conte Verde fu fatta edificare nel 1700 dal prevosto di Condove, don Tommaso Cazzolo. Nel 1752 il prevosto di Condove, don Giovanni Antonio Pola, fece costruire la tribuna e il portico antistante la cappella. La cappella della Madonna delle Grazie fu visitata nel 1825 e risultava essere stata da poco restaurata.
La cappella sorge isolata, circondata dai resti dell’antico Castrum Capriarum a Condove. L’edificio si appoggia ad un muro medievale del Castrum, sul quale si sviluppa la sacrestia e l’aula a pianta rettangolare, preceduta da un porticato a pianta quadrata con aperture ad archi a tutto sesto. La facciata è dunque disegnata dal portico, profilata a capanna, terminata dal timpano triangolare e racchiusa ai lati da lesene con capitelli pseudo-ionici. Il campanile “a vela” è stato aggiunto sul muro d’ambito sinistro. L’edificio si sviluppa secondo un impianto a navata unica e il portico costituisce il sostegno per la cantoria che si apre all’interno della controfacciata.
Lo schema planimetrico è a navata unica conclusa da abside piatta, voltata a botte con unghie, affiancata sul lato sinistro da un’ampia sacrestia a pianta quadrangolare; porticato a pianta quadrata coperto da volta a crociera. Muratura portante di tipo misto, intonacata e tinteggiata esternamente in facciata, lasciata ad intonaco al naturale sui restanti lati; interno intonacato e tinteggiato.
Nell’area absidale è presente l’altare barocco in stucco e muratura, composto da due colonne tortili che reggono una timpano decorato a volute, sul quale poggiano due putti ritratti nell’atto di scostare un tendaggio che rivela una gloria di angeli posta sotto un baldacchino.
Cappella S. S. Madonna degli Angeli al Collombardo
La prima costruzione fu un pilone con dipinta in una nicchia la Madonna tra San Giovanni Battista e San Grato, l’aveva eretto Giovan Battista Giorgis nativo del Forno di Lemie per grazia ricevuta verso il 1680. Circa 25 anni più tardi nel 1705 sempre Giorgis iniziava i lavori per erigere una piccola cappella dedicata alla Madonna degli Angeli incorporando il pilone esistente. I lavori furono ultimati l’anno successivo per la festa della cappella.
Fu benedetta il 2 agosto 1706 giorno della festa dal prevosto di Mocchie Don Giovanni Pietro Costa con l’assistenza del Curato di Frassinere Don Francesco Aymone e dal Cappellano di Laietto Don Bernardino Cuffia. Era la prima festa del Collombardo, un rito che si ripeterà ogni anno fino ai giorni nostri. Purtroppo queste feste furono in alcuni anni funeste causa la rivalità tra Mocchiesi e Lemiesi che portavano a dispute e scontri.
La cappella era limitata in capienza in rapporto al numero di fedeli, per cui si costruì una sacrestia ed una tettoia sulla facciata. Più tardi si aggiunsero altre due tettoie ai lati e un presbitero abbattendo il pilone e così rimase fino alla sua ricostruzione. Questa avvenne grazie a Monsignor Giuseppe Vinassa parroco di Laietto. Nel 1869 iniziarono i lavori che terminarono in via provvisoria l’anno successivo con nuova benedizione della cappella. I lavori ripresero nel 1879 e proseguirono a fasi alterne fino al 1905. Il tutto fu possibile grazie anche alle prestazioni volontarie gratuite della popolazione di Laietto.
Altri interventi furono eseguiti negli anni successivi quando la parrocchia di Laietto era retta da Don Giovanni Battista Margaria sino ad arrivare quasi alla configurazione attuale. Nel 1979 un tornado asportò completamente il tetto del Santuario che fu ricostruito negli anni successivi grazie ai contributi di varie associazioni oltre che della popolazione di Condove.
Cappella di Santa Lucia alla borgata Colombatti
La visita pastorale compiuta nel 1782 menziona un’iscrizione all’interno della cappella, la quale recava l’indicazione della fondazione della medesima nell’anno 1609.
La cappella di Santa Lucia sorge isolata, in posizione panoramica a Colombatti, frazione di Condove. La facciata, profilata a capanna, presenta il vano d’ingresso, aperto, delimitato da due pilastri a base quadrata sorreggenti un’arco molto ribassato. La copertura è a due falde con manto di copertura in coppi. L’edificio si sviluppa secondo un impianto a navata unica, terminato da abside semicircolare.
Lo schema planimetrico è a navata unica voltata a botte con unghie, conclusa da abside semicircolare coperta da calotta e preceduta da un portico. Muratura portante in pietrame intonacata, tinteggiata esternamente sulla facciata principale e senza colore sulle altre. Interno intonacato, tinteggiato e decorato. In controfacciata è presente la cantoria lignea alla quale si accede attraverso una scala a chiocciola.
Cappella di San Pietro in Vincoli (vecchia chiesa parrocchiale sconsacrata) a Condove
L’edificio della vecchia Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli che si affaccia sulla piazza S. Pietro, ora dissacrato, era in origine una cappella dedicata a San Carlo Borromeo costruita nel 1625 a quindici anni dalla canonizzazione. La cappella fu ampliata di una navata ad occidente nel 1755, in vista della sua trasformazione a chiesa parrocchiale, sotto il titolo di San Pietro in Vincoli. La nuova funzione di parrocchiale iniziò ufficialmente nel 1757, mentre nel 1782, su proposito del Prevosto teologo don Michele Pettigiani, fu portata alla sua capienza attuale.
Nel 1959 la chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli fu ridotta a cappella a seguito dell’entrata in funzione della nuova parrocchiale sita in via Roma, sempre dedicata a San Pietro in Vincoli. Tra il 2013 e il 2015 l’intero edificio è stato sottoposto a consolidamento e restauro conservativo, con rifacimento del manto di copertura e restauro delle decorazioni interne. La facciata, sulla quale si aprono tre portali, si presenta tripartita con cornici marcapiano, timpani e mezzi timpani decorati a volute. L’interno si presenta a tre navate separate da pilastri a pianta quadrata. Le navate laterali ospitano cappelle, mentre la navata principale termina con abside. Il campanile a vela si innesta sulla copertura al termine della navata laterale sinistra.
Le navate presentano una decorazione a stucco marmoreo datata al 1838. Le volte, decorate nel 1898 dal pittore don Pietro Mentasti, raffigurano nella cupola l’Apologia di San Pietro, sulla volta della navata centrale la pesca miracolosa, la liberazione dal carcere e la crocifissione; nelle lunette delle finestre, scene raffiguranti le Litanie Lauretane. In presbiterio sono presenti due tele raffigurati il conferimento del Primato di Gesù e Gesù che salva San Pietro sul lago. Nella navate minori sono presenti motivi decorativi ottocenteschi sopra un precedente impianto decorativo a putti danzanti probabilmente tardo settecentesco.
Cappella di San Rocco già Santa Maria del Prato a Condove
L’antica chiesa parrocchiale, dedicata a S. Maria del Prato poi a San Pietro e infine a S. Rocco, con l’annesso antico cimitero, venne costruita probabilmente verso il XII secolo stando alla struttura del campanile dalle chiare forme architettoniche romaniche. Nel 1290 gli abitanti di Condove autorizzati dalla Certosa di Montebenedetto si approvvigionarono di legname sui monti di Villarfocchiardo per eseguire delle riparazioni alla chiesa di Santa Maria del Prato danneggiata forse dalle frequenti inondazioni causate dal Rio della Rossa che scorreva a monte dell’abitato. Nel 1730 la bifora più elevata del campanile fu ampliata per permettere l’inserimento della nuova campana.
Nel 1757, con l’apertura al culto della nuova parrocchiale di San Pietro in Vincoli, la chiesa parrocchiale vecchia fu degradata al rango di cappella. L’antica parrocchiale di Santa Maria del Prato, poi dedicata a San Pietro in Vincoli, assunse l’attuale denominazione a San Rocco nel 1929, a seguito della demolizione della cappella dedicata al santo sita nella piazza del mercato in centro paese.
La cappella di San Rocco è stata sottoposta a interventi di restauro e indagine archeologica tra il 1993 e il 1998. Durante i lavori di restauro, nella fase di scavo dell’abside antica è stato ritrovato un pezzo di oreficeria, in bronzo e smalto, raffigurante la Crocifissione, ora al Museo Diocesano di Susa ed inoltre i sondaggi hanno messo in luce una parte di affresco dell’arco trionfale, considerato dagli esperti forse il più antico esistente in valle.
L’edificio è il risultato di una ristrutturazione dell’aula di culto, che ha lasciato intatto il preesistente campanile, di età romanica, il quale resta affiancato alla facciata; il campanile è in pietra lasciata a vista, slanciato per cinque piani, decorato da archetti pensili e con finestre bifore aperte nei tre piani più alti. L’aula di culto si sviluppa su uno schema a navata unica coperta da un soffitto in tavolato ligneo sostenuto da capriate, conclusa da un’abside semicircolare. Una cantoria con balaustra in legno è appoggiata alla controfacciata.
Cappella di Sant’Antonio da Padova alla borgata Gagnor
La cappella fu edificata tra il 1862 e il 1864 per volere di Giuliano Croce di Mocchie e grazie ad un lascito testamentario di Giacomo Perotto.
Sorge isolata in posizione panoramica in località Gagnor. La facciata è profilata a capanna con le falde del tetto sporgenti a coprire l’ingresso; questo si attua attraverso il portico, mediante un arco a tutto sesto; la parete di facciata presenta una finestra polilobata ed è conclusa dal timpano triangolare. Affiancata ad essa, in linea con la facciata è situato il massiccio campanile in pietra lasciata a vista, terminato da una cuspide. L’edificio si compone di un’aula a pianta rettangolare, preceduta da un portico, e conclusa da un’abside semicircolare
Lo schema planimetrico è a navata unica voltata a botte, preceduta da un piccolo portico e conclusa da un’abside semicircolare con catino semisferico. Muratura portante in pietrame intonacato, tinteggiato in facciata e lasciato a vista sui restanti lati. Interno intonacato e tinteggiato.
Cappella della Trinità tra le case Gestia e Gare
Antica cappella risalente al XVI secolo, ormai diroccata posta su un dosso roccioso a valle della borgata Maffiotto tra le case Gestia e Garello lungo la mulattiera che da Maffiotto scende a San Didero, con ampia vista sul fondovalle. La cappella era meta di un pellegrinaggio annuale, con partenza dalla chiesa di Frassinere.
Cappella di San Martino alla borgata Grange
La cappella di San Martino alle Grange di Maffiotto è citata per la prima volta nel 1744, in occasione della visita pastorale dell’abate Delle Lanze. La facciata è profilata a capanna, protetta dall’aggetto delle due falde del tetto, sorrette dal muro d’ambito e da un pilastro. Il portico così generato è coperto da tavolato ligneo su capriate con manto di copertura in lose. L’aula di culto si articola secondo uno schema a navata unicapreceduta da un ampio portico, conclusa da abside piatta e voltata a botte con unghie. Un piccolo campanile emerge a destra rispetto alla facciata. Muratura portante di tipo misto intonacata, tinteggiata sulla facciata principale e senza colore sulle altre. Intonacata e tinteggiata internamente.
Cappella di San Bernardo d’Aosta alla borgata Laietto
Non vi sono documentazioni dettagliate circa la fondazione o le origini della cappella, ma le opere d’arte presenti nella cappella di San Bernardo d’Aosta indicano come fosse già fiorente prima del 6 novembre 1430 data a cui risalgono gli affreschi gotici all’interno dell’abside.
La cappella di San Bernardo a Laietto, posta a valle dell’abitato, occupa l’angolo sud est del cimitero della frazione, ed è prossima all’antica mulattiera che da Condove raggiunge il Collombardo. Le informazioni storiche relative a questo edificio sono scarse, si ipotizza la realizzazione di un corpo di fabbrica in un periodo tra l´XI e il XIII secolo, quindi una seconda fase costruttiva tra il XIV e la prima metà del XVI secolo. L’edificio è costituito da un corpo principale parallelepipedo, cui si affianca un altro volume, di dimensioni più piccole, che ospita l’area absidale.
Le superfici interne dell’aula sono intonacate e tinteggiate, mentre l’area absidale, presenta un interessante ciclo di affreschi. Un’iscrizione in gotico porta la data del 6 novembre 1430 e il nome del committente, “Antonio di Laietto, figlio di Michele”.
Il ciclo affrescato è composto da riquadri autonomi: sulla parete nord san Michele e san Bernardo d’Aosta; sulla parete frontale al centro la Madonna in trono con il Bambino ed alla sua sinistra santa Caterina. Di seguito, sul muro destro, compaiono santa Margherita e sant’Antonio abate; subito dopo l’arco trionfale, a sinistra, compare una figura di difficile identificazione, probabilmente santa Maddalena o santa Barbara. Sulla volta, in quattro riquadri, i simboli degli Evangelisti.
Cappella di San Barnaba alla borgata Magnoletto
La cappella di San Barnaba in borgata Magnoletto fu fatta edificare per volontà degli abitanti nel 1774. La cappella fu visitata dal vescovo di Susa mons. Lombard nel 1825 e se ne ordinò il risanamento dall’umidità mediante la creazione di un’intercapedine e l’asportazione del pergolato adiacente ad una parete laterale, nonché la riparazione del tetto. La facciata è profilata a semplice capanna, con copertura a due falde e manto in lose che si protendono a coprire l’ingresso; questo è affiancato da due finestrine quadrate e sovrastato da un ad oculo ovale. Il campanile “a vela” è posto in asse. L’edificio si sviluppa su uno schema a navata unica conclusa da abside piatta, coperta da volta a crociera. Muratura portante di tipo misto intonacato, tinteggiata esternamente in facciata e lasciata ad intonaco al naturale sui restanti lati; interno intonacato e tinteggiato.
Altare marmoreo con base cementizia. L’intervento di adeguamento liturgico tra il 1980 e il 1990 ha previsto la riorganizzazione generale dell’area presbiteriale, con la realizzazione di una nuova mensa d’altare in marmo, che ha comportato la rimozione dell’altare originario.
Cappella S. Antonio da Padova alla borgata Molaretto
Cappella in Via Angelo Perodo a Condove ricostruita sul finire degli anni 20 del secolo scorso dal geometra Guido Perodo. La cappella anticamente era patronato della famiglia Bruno come ricorda la visita pastorale dell’abate Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze del 1744.
Perodo Guido fece demolire la vecchia e rovinata cappella dedicata a S. Antonio da Padova e ne fece ricostruire un’altra, dignitosa e accogliente, che venne solennemente inaugurata da S. Ecc. Monsignor Rossi, vescovo di Susa, e dalle autorità locali nel mese di luglio 1929. In una lapide murata nell’interno della cappella sono incisi i nomi dei dieci componenti la figliolanza di Perodo Luigi e Rumiano Domitilla con relativa data di nascita e di morte.
Cappella di San Rocco alla borgata Mollette – Girardi
La cappella di San Rocco in borgata Mollette è citata per la prima volta nella visita pastorale dell’abate Delle Lanze del 1744. All’epoca risultava fatta edificare dalla popolazione della borgata.
La facciata è profilata a capanna. Sul muro d’ambito sinistro si alza il campanile “a vela”, mentre in asse all’ingresso è posta una piccola finestra polilobata. L’ingresso è protetto dall’aggetto degli spioventi del tetto, con manto di copertura in lose.
Lo schema planimetrico è a navata unica conclusa da abside piatta e coperta da volta a crociera. Muratura portante di tipo misto intonacata, tinteggiata con zoccolatura in pietra in facciata, lasciata con intonaco al naturale sui restanti lati. Interno intonacato, tinteggiato e rivestito da perlinatura. In controfacciata è presente una grande cantoria in legno, completamente tinteggiata, alla quale si accede mediante una scala in legno.
Cappella di Sant’Agostino alla borgata Poisatto
La cappella di Sant’Agostino fu visitata nel corso della visita pastorale di mons. Marozio nel 1904 e risultava in buono stato. Fu restaurata nel 1952 e ancora nel 2005.
La cappella di Sant’Agostino sorge a Poisatto a Condove all’interno del centro abitato. La facciata è profilata a capanna, preceduta da un portico e conclusa in sommità dalla cornice e segnata ai lati da lesene di ordine tuscanico; l’apertura di accesso al portico è ottenuta attraverso un arco a sesto molto ribassato, sormontato da una finestra polilobata. Il campanile “a vela” prosegue sul muro d’ambito laterale a sinistra rispetto alla facciata. L’edificio si articola secondo uno schema a navata unica preceduta da un portico, coperti entrambi da volte a vela. In controfacciata al di sopra del portico è presente una cantoria in muratura. Muratura portante di tipo misto intonacato, tinteggiata esternamente in facciata, lasciata ad intonaco al naturale sui restanti lati; interno intonacato e tinteggiato. Una cornice continua corre all’innesto della volta, sottolineata negli angoli da lesene.
Cappella della Madonna della Neve alla borgata Prarotto
La cappella fu edificata nel 1828 per volere degli abitanti delle borgate Grange, Crosatto, Cugno e Maffiotto. Fu benedetta nel medesimo anno. Il campanile fu edificato e dotato di campana nel 1834.
Nel 1839 furono ultimati i lavori di rifinitura della cappella. La cappella fu restaurata sia internamente che esternamente ad opera degli abitanti della borgata nel 1936
La cappella della Madonna della Neve, sorge isolata e in posizione elevata a Prarotto di Condove. La facciata è profilata a capanna, segnata da riquadri e dal timpano triangolare dove si nota l’ampio arcone del porticato chiuso ai lati dai muri d’ambito. Il campanile è posto sul lato sinistro rispetto all’ingresso. Il tetto è a due falde con copertura in lose. L’aula di culto si articola secondo uno schema a navata unica coperta da volta a botte con unghie, conclusa da abside piatta e preceduta da un porticato coperto. Una piccola cantoria lignea è appoggiata alla controfacciata. Muratura portante in mattoni intonacata e tinteggiata esternamente in facciata, lasciata ad intonaco a vista sui restanti lati; interno intonacato, tinteggiato e rivestito da assito in legno al naturale sulle pareti.
Cappella di San Lorenzo alla borgata Prato del Rio
La cappella di Prato del Rio è citata nella relazione sullo stato della parrocchia redatta nel 1820. In essa si affermava che la cappella era interdetta da lungo tempo a causa del cattivo stato, e che si sarebbe provveduto a riedificarla. La cappella è stata completamente restaurata nel 2002
La cappella di San Lorenzo sorge isolata in località Prato del Rio a Condove. La facciata è profilata a semplice capanna, la copertura a due falde, con manto di copertura in lose, si protende a proteggere l’ingresso: una semplice porta in legno affiancata da due aperture di modeste dimensioni. Un campaniletto “a vela” è posto in asse. L’edificio si sviluppa ad aula a pianta rettangolare, terminata da abside semicircolare.
Lo schema planimetrico è a navata unica voltata a botte con unghie, conclusa da abside semicircolare voltata a calotta. Muratura portante in pietrame lasciato a vista esternamente su tutti i lati, intonacato e tinteggiato internamente. La copertura dell’aula è impostata su una cornice che corre continua. Una “catena” in legno è posta, per rinforzare la volta, sulla linea di delimitazione della zona presbiteriale.
Cappella Immacolata Concezione alla borgata Pratobotrile
La cappella risultava già esistente nella visita pastorale del Vicario Abbaziale di San Giusto Vignale del 1624 e nel 1643 era ancora di proprietà degli eredi di Gaspare Vinassa, che l’aveva fatta edificare rifornendola di tre emine di frumento e quattro libbre di burro in cambio della celebrazione di diciotto messe in suffragio della sua anima. Don Mercandini la descrive simile a quella dedicata a San Bernardo a Laietto. Fu ampliata nel 1762 ma conservò una struttura semplice ad una sola navata. La facciata è profilata a capanna, conclusa da un timpano triangolare e decorata da trabeazione, cornice e da quattro lesene di ordine “gigante”. La semplice porta di ingresso è sormontata da una edicola mistilinea affrescata con l’effige della Madonna in gloria, a sua volta sovrastata da un oculo circolare. Il manto di copertura è in lose e il campanile, con terminazione tronca, è appoggiato sul lato sinistro del muro d’ambito. Internamente si sviluppa secondo un impianto a navata unica voltata a botte, che si restringe nel presbiterio, conclusa da abside semicircolare voltata a calotta. Addossata alla controfacciata è presente la cantoria lignea una grande balconata a pannelli in legno, alla quale si accede attraverso la scala appoggiata alla parete laterale. Muratura portante intonacata e tinteggiata esternamente in facciata, lasciata ad intonaco grezzo sui restanti lati. Interno intonacato, tinteggiato e decorato. Un’alta cornice corre lungo tutte le pareti a sottolineare l’imposta della volta.
Cappella del Beato Nome di Maria alla borgata Ravoire
La cappella fu edificata e benedetta nel 1820 e sorge isolata in posizione panoramica alla borgata Ravoire. La facciata è profilata a capanna, con il campanile “a vela” posto in asse; essa è preceduta da un piccolo portico ottenuto prolungando lo spiovente del tetto, con manto di copertura in coppi. L’aula di culto è a navata unica, su pianta rettangolare con abside piatta. Una cantoria è addossata alla controfacciata.
Lo schema planimetrico è a navata unica conclusa da abside piatta, coperta da volta a botte con unghie. Muratura portante di tipo misto intonacato e tinteggiato esternamente in facciata, lasciato ad intonaco al naturale sui restanti lati; interno intonacato, tinteggiato e rivestito da perline. In controfacciata è collocata la cantoria alla quale si accede attraverso una scala lignea.
Cappella di San Sebastiano alla borgata Reno Inferiore
La cappella di San Sebastiano al Reno Inferiore fu edificata intorno al 1724 e fu visitata per la prima volta dall’abate di S. Giusto di Susa nel 1744. La facciata è profilata a capanna, in asse è posto il campanile “a vela”. La copertura del tetto a due falde, con manto in lose, si protende a coprire l’ingresso: una semplice porta in legno affiancata e sovrastata da finestre di modeste dimensioni. Si articola secondo uno schema a navata unica conclusa da abside piatta e voltata a botte. In controfacciata è presente una cantoria. Muratura portante di tipo misto intonacata, tinteggiata sulla facciata principale e senza colore sulle altre. Interno intonacato e tinteggiato. La cantoria in muratura, sostenuta da colonne cilindriche con archi, si appoggia alla controfacciata.
Cappella di San Giovanni Battista alla borgata Reno Superiore
La cappella di San Giovanni Battista al Reno Superiore è citata per la prima volta in occasione della visita pastorale dell’abate Delle Lanze, nel 1744
La cappella sorge all’interno del centro della borgata. La facciata è profilata a semplice capanna e in asse si eleva il campaniletto “a vela”. Le due falde del tetto, con manto di copertura in lose, si protendono sulla facciata per proteggere l’ingresso: una porta a due ante a listelli di legno inchiodati affiancata da una piccola apertura sul lato destro. L’aula di culto si articola secondo uno schema a navata unica conclusa da abside piatta e voltata a botte unghiata. Muratura portante di tipo misto intonacata, tinteggiata nella parte bassa della facciata principale con tracce di un affresco nella parte alta raffigurante l’annunciazione contornata da San Michele a sinistra e altro santo sconosciuto a destra. Intonaco senza colore sulle altre pareti. Intonacata e tinteggiata con tracce di altri affreschi internamente.
Cappella di San Grato alla borgata Rocca
La cappella della Rocca è antichissima ed è citata nella visita fatta dall’Abate Caroccio, Vicario Generale, il 24 settembre 1658 con l’ordine di riparare la volta a spese dei particolari ed era intitolata a San Benedetto. Citata anche in una seconda visita nel 1744, dall’abate di San Giusto di Susa . Successivamente nel 1820 è stata dedicata a San Grato. In tale occasione se ne rilevò il buono stato di conservazione.
La cappella sorge isolata tra le borgate di Rocca e Dravugna, in posizione panoramica. La facciata è intonacata come il campanile, a differenza delle altre pareti, ed è decorata da una fascia marcapiano che la divide in due registri, da due lesene che ne scandiscono tre porzioni verticali, e terminata da un timpano triangolare. Il tetto è a due falde con copertura in lose. L’edificio si compone di un primo spazio a giorno, un atrio, in parte occupato dalla base del campanile, che introduce all’aula di culto di pianta rettangolare, più ristretta nella zona presbiteriale e terminata da abside piatta; sul lato destro del presbiterio è affiancata una piccola sacrestia. Un’ara romana di pietra è stata reimpiegata come sostegno di acquasantiera.
La struttura è in muratura portante di pietrame intonacato, tinteggiato esternamente in facciata, lasciato a vista sui restanti lati; interno intonacato, tinteggiato e affrescato. Le volte sono impostate su cornice e sottolineate da lesene. In buono stato di conservazione esterno, discreto interno.
Durante i restauri iniziati nel 2006 ulla parete sinistra della navata e nell’area absidale sono emerse tracce di affreschi. Il primo affresco rappresenta dei personaggi seduti presso una lunga tavola imbandita con vari cibi. Intorno si affaccendano dei servitori che portano vassoi di frutta e grandi coppe. Gli esperti lo interpretano come una raffigurazione delle Nozze di Cana, con il miracolo dell’acqua trasformata in vino, miracolo al quale alluderebbero le figure dei servitori che portano in tavola delle coppe. Il secondo affresco è molto frammentario. Vi si riconosce una figura maschile in abiti seicenteschi intenta a legare un uomo spogliato, si tratta probabilmente di una scena di martirio. Quest’ultimo rivela la mano di un artista in parte aggiornato sulla pittura barocca di metà Seicento in Piemonte, assai prossimo al pittore che realizzò vari affreschi a Mompantero, detto il “Maestro del Seghino”.
Cappella San Stefano alla borgata Sigliodo Inferiore
La cappella di Santo Stefano sorge nella borgata Sigliodo Inferiore e fu costruita nel 1925. La facciata è profilata a capanna, conclusa ai lati da lesene e sovrastata dal timpano triangolare; la cornice inferiore di esso si incurva per ricevere una finestra centinata, sottostante è un’edicola con effige della Madonna e Bambino in trono. In asse vi è il campaniletto “a vela”. Internamente l’edificio si sviluppa secondo un impianto a navata unica, terminato da un’abside semicircolare. Sulla controfacciata è addossata una cantoria lignea alla quale si accede mediante una scala anch’essa in legno. All’esterno la facciata si presenta intonacata, tinteggiata e decorata con una zoccolatura a finta pietra, mentre i restanti lati sono ad intonaco al naturale.
Cappella della Madonna delle Grazie alla borgata Sinette
Le prime notizie dell’edificio risalgono al 7 giugno 1743 giorno in cui il vicario abbaziale, don Antonio Baroverio visitò la cappella, la cui costruzione iniziò nel1705 e fu benedetta a settembre 1706.
La cappella è citata all’interno della relazione sullo stato della parrocchia redatto nel 1820. In tale occasione essa fu definita bellissima e in ottimo stato. Fu oggetto di restauri nel 1868-1870 che ampliarono la cappella dotandola di un portico e del campanile.
La cappella della Madonna delle Grazie sorge isolata a Sinette lungo la mulattiera che collegava Mocchie a Frassinere. La facciata, intonacata, è conclusa dal timpano triangolare, scandita da quattro lesene che contengono le tre aperture arcuate del portico, e segnata da un’alta trabeazione; sul fianco sinistro è appoggiato un imponente campanile a pianta quadrata. Il tetto è a due falde con manto di copertura in lose. Internamente si compone di un’aula a navata unica, conclusa da abside piatta, coperta da due campate di volte a vela, dove quella prossima all’ingresso è stata tramezzata per ricavare il piccolo atrio porticato. Muratura portante di tipo misto intonacato e tinteggiato esternamente in facciata, lasciato ad intonaco al naturale sui restanti lati. Interno intonacato e tinteggiato. La decorazione architettonica interna, semplice, è formata da lesene e cornice d’imposta delle volte.
Vicino alla cappella esiste un più antico pilone votivo dedicato alla Madonna che ha la particolarità di esibire anche un affresco con San Carlo Borromeo che prega ai piedi della Sindone, che ricorda il viaggio a piedi dell’arcivescovo milanese a Torino nel 1578 per ringraziamento dello scampato pericolo della peste dell’anno precedente.
Cappella di San Michele Arcangelo alla borgata Vianaudo
La cappella di San Michele a Vianaudo è citata per la prima volta in occasione della visita pastorale dell’abate Delle Lanze, nel 1744 e fu restaurata nel 1903. Sorge isolata, immersa nel verde in posizione panoramica a Vianaudo di Condove. La facciata è profilata a capanna, con il timpano triangolare segnato da una cornice, una finestra ad oculo al centro, e la porta d’ingresso disassata. La copertura del tetto a due falde, con manto in tegole di cemento, si prolunga a protezione dell’ingresso. L’aula di culto si articola secondo uno schema a navata unica conclusa da abside piatta e coperta da volta a botte molto ribassata. Costruita con muratura portante di tipo misto intonacata, tinteggiata sulla facciata principale e senza colore sulle altre. Internamente intonacata, tinteggiata e decorata.
Cappella di san Rocco a Villa di Mocchie
L’origine di questa cappella, da principio piccolissima, si attribuisce a un voto della popolazione per essere salva da una gravissima epidemia. La sua costruzione si fa risalire al 1660 visto che non se ne trova memoria nelle visite pastorali antecedenti. Chi ne sostenne la spesa deve essere stato il popolo col contributo del Comune. In seguito alla visita del1744 dell’abate delle Lanze che la trovò non più servibile al culto fu interamente riedificata. Poi 22 anni dopo, essendo mancata la Chiesa antica, dovette servire per qualche tempo alle funzioni parrocchiali. Sebbene ben presto venisse ampliata (1766) dal presbiterio alla porta.
Cappella di Sant’Antonio da Padova alla borgata Volpi – Valgravio – Mogliassi
La cappella di Sant’Antonio in regione Valgravio è citata per la prima volta in occasione della visita pastorale dell’abate Delle Lanze, nel 1744. Fu interamente restaurata nel 1909
La cappella di Sant’Antonio sorge su un cucuzzolo ben visibile dalle borgate Volpi, Mogliassi e Rosseno di Condove. La facciata è profilata a capanna, la copertura del tetto a due falde è avanzata a proteggere l’ingresso e sostenuta da due pilastri a base quadrata. Sovrasta la porta una finestrina a mezzaluna, l’affiancano altre due piccole finestre quadrate. Un piccolo campanile prosegue sul muro d’ambito di destra. L’edificio si sviluppa secondo un impianto a navata unica preceduta da un porticato. Dietro l’altare c’è un bellissimo affresco e le pareti sono coperte da quadri votivi donati nel tempo dalla popolazione.
Lo schema planimetrico è a navata unica coperta da un controsoffitto piano, conclusa da abside piatta e preceduta da un ampio porticato. Muratura portante di tipo misto intonacata, tinteggiata sulla facciata principale e senza colore sulle altre. Internamente, perlinata sulle pareti a mezza altezza, intonacata e tinteggiata sulle restanti parti.
Gianni Cordola