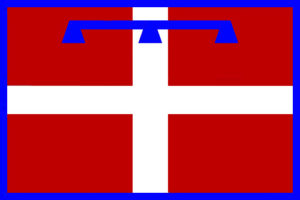La montagna nel passato era vissuta molto diversamente da oggi: la vita era connaturata con l’ambiente, dal quale si ricavava ogni sostentamento. La nuda terra e il bosco erano elementi da cui dipendeva la sopravvivenza delle famiglie, attraverso una serie di attività agricole e forestali, scandite da un secolare calendario.
Ogni stagione era connotata da specifiche lavorazioni: in primavera si concimavano e si aravano i campi per le semine (cereali, patate e legumi), e in estate si falciavano i foraggi, si mietevano i cereali (orzo, segale, avena e grano).
La segale è un cereale di antichissima origine, conosciuto in Europa e sulle Alpi da circa 3000 anni e molto utilizzato nelle borgate in quota perché più resistente e rustico del frumento. La segale, infatti, non richiede terreni preparati e talora si trova addirittura, infestante, nei campi di frumento, inoltre tollera bene le condizioni climatiche umide e fredde dei terreni alpini.
Con la farina di segale i montanari ricavavano il pane nero come è comunemente conosciuto il pane di segale a causa del suo caratteristico colore scuro, prodotto tipico di tutto l’arco alpino. Si tratta di un pane povero, utilizzato nella cucina contadina dell’area alpina e un tempo tenuto in scarsa considerazione. Oggi, invece, è ricercato per le sue qualità nutritive e i suoi aromi antichi e genuini: la segale è infatti molto energetica e ricca di sostanze e di elementi essenziali molto importanti per l’organismo. Il gusto è leggermente acidulo, la mollica è morbida, di colore tendente al grigio-scuro, la crosta è croccante, dorata e speziata. Veniva cotto poche volte l’anno in condizioni di luna crescente per favorire la lievitazione e pare che il pane cotto in questi periodi si conservasse meglio e non ammuffisse.
Un secolo fa mia nonna il pane nero lo faceva così: preparava l’impasto classico con farina di segale, acqua, sale, lievito (lievito naturale riprodotto da un precedente pezzo d’impasto che si era lasciato riposare e prendere una naturale acidità sotto un piatto rovesciato in un angolo della dispensa). Una volta impastato e lavorato nella forma tipica rotonda od ovale alta 5 o 6 centimetri, le forme venivano affiancate l’una all’altra su una lunga tavola di legno. Una volta arrivata al forno della borgata, che aveva prima provveduto a preparare dando fuoco alle proprie fascine di legna, procedeva alla cottura. Cotto il pane lo si conservava per i giorni che seguivano nella tipica madia costruita con il coperchio bombato da cui prendeva il nome, una sorta di contenitore in legno povero ma quasi sempre abbellito con decori incisi, quasi privo d’aria, che lasciava il pane in sottovuoto naturale, un aiuto per la sua lunga conservazione. Il pane degli ultimi giorni, ovviamente non più tanto fresco, ma anzi abbastanza indurito ormai, non andava gettato via, era ancora buono per essere utilizzato per condire minestre o altro.
Gianni Cordola