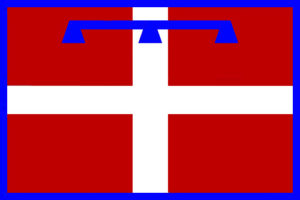Mè pare a m’arpetìa sempe: “Nòsta a l’é na famija ‘d campagnin e ‘dcò ti ‘t saras campagnin.” Mi nò ch’j’era pa content! Da pòch a l’era finìa la guèra e la vita ‘n montagna a më smijava tròp dura; mi sugnava na vita pì bela ‘n sità, cola sità che ij vej a ‘rfasìo përgna d’arcan: “Vëdde là bass an fons dla pian-a: Turin!” sìmbol d’un mond contà da coj pòchi viagiator ch’a j’ero staje. Cand ch’a l’é vnù ‘l moment ëd decide i l’hai pa avù ‘d dubi e i son andàit a la stassion ëd la stra ‘d fer dël pais. Pijo ‘l bijèt për Turin e, spetand ël treno, la vita ‘m passa dnans birosa e tuta l’istessa. Un subi e l’ësbofé dla motriss a vapor am dësnandia dai crussi.
Monto e ‘m seto s’un sedil ëd bòsch avzin al finestrin ëspetand ansios ël subi dël cap-ëstassion. Con n’ësfrajé ‘d roe, ‘l treno as bogia prima pian pianòt e peui sempe pì biros. Mi, ancolà al finestrin, im faso robé da lë spetàcol ch’i l’hai dnans: ij mè euj a vëddo ‘n balèt ëd pra verd spassià da ca e bòsch, un senari fantàstich për mi chërsù ‘nt na cita borgià ‘d montagna trames a ròche, a pascoj e pa mach che le vache a feme companìa. L’armor ëd le roe sij binari a consìa la ment e a giuta a tajesse fòra dal mond; ma dj’àutri viandant a monto sù a le fërmade ch’a ven-o apress e ‘nt l’aria ‘s dësparpaja na spussa ‘d sigala…
Finalment i rivo an sità. Feura dla stassion i levo j’euj al cel, ch’a l’era pì nen bleussiel coma ch’i lo vëddìa ‘n montagna, ma gris sënner; l’aria a l’era pì greva; le ca àute pì che quatr bàite butà un-a sl’àutra; le fomne a pòrto ‘d caplin ch’a smijo ni ‘d merlo e j’òmo, pitòst che la cabassa, a pòrto na borsa: tuti a marcio ‘n pressa sensa parlé. Ma coma ch’a l’é rumorosa la sità, i l’hai pensà. Traverso la stra, ma na ciochinà ‘m fa ‘rsauté: a l’é ‘n tranvaj, ël prim ch’i vëddìa.
Sempe pì sle mie, i rivo da l’àutra part ëd la stra e i vado vers na piassa pien-a ‘d gent ch’as pistava, ch’as possonava, ch’as n’andasìa sghëmmonand; për tèra j’era ‘d baron ëd minca sòrt ëd marcansìa, franch ‘me a la fera dël pais. Ësta piassa së s-ciama Pòrta Pila e sì as treuva ‘d tut: ëd brajëtte, ‘d cotin, ëd sòco, ancor ëd tomàtiche, ‘d tòme, ‘d bur, ëd polastr, ëd colomb e ‘d quaje, fin-a j’arnèis ëd cusin-a, e ‘d trapole për ij giari e d’àutra sòrt ëd prodot.
Na furfa ‘d fomne, ‘d servente, ‘d campagnin, as bogia con flema, fërmandse dnans a la ròba, ‘dcò arciamà da j’anvit dij bateur: “Ch’a ven-a avanti madamin, bela ròba a bon pat!”. Ëstordì m’avzin-o për caté quaicòs da mangé, ma ‘nt le sacòce a-i son pa pì ij sòld ch’l’ha dame pare; antlora i marcio sensa na mira, gaboland daspërmi su coma l’hai podù femje robé ò perdje.
Anvers l’ambrunì i ciamo a ‘n civich s’a-i fussa na quàiche fnera anté podèjme ‘rposé. Cost, am varda sbafumà coma s’i fussa ‘n fòl e, con un gest, am fa vëdde na piòla. Andrinta, l’aria l’era greva e fumosa, it veusto për le tròpe person-e present, ma dzoratut për ël fum dij toscan e l’arfiaj dël vin.
Ëd sitadin, pijà pòst a l’antorn ëd na tàula e comandà ‘n lìter ëd col bon, a s’anformo sle neuve dla giornà. Dj’àutri, pòch pi ‘n là, dnans a ‘n cit pùblich d’atent spetator, a s’asardo ‘nt ël rumoros gieugh ëd la mora, ‘nterdì ma ‘ncor sempe butà ‘n pratica.
L’òsto, ch’a fa da padron a cost andé e vnì ‘d gent ëd minca posission sossial, a l’é ‘n gran drito e, pen-a ch’a capiss ch’i son sensa dné, tut sùbit am possa a l’uss. Përparèj ‘rtorno a la piassa dël mërcà; ‘ntant che ij mërcandin artiro la ròba, i cheujo për tèra doi pom gianinà: sempe mej che gnente.
Magonà, ‘rtorno a la stassion dla stra ‘d fer; setà ‘nt la sala d’aspet i stago për andurmime, cand doi òmo ‘n divisa ‘m sopato, e dòp avèj arvëddù ij papé am fan seurte.
Basta, i n’hai pro! Coma ch’am manca la naturalëssa dle cite còse ‘d cola vita ch’i chërdìa greva, nopà a l’era la pi bela. I l’hai vorsù toché con man na neuva realtà, e i l’hai dëscheurvì coma ch’i j’era beà ‘nt la mia borgià, con un bicer ëd vin a la cantin-a e le quatr ciaciarade con j’amis, sota ‘l cel bleussiel e l’aria bon-a, an col ambient anmascà ‘d montagna.
Artorno a ca a ‘rtrové mie ròbe, cite ma ‘d gròss valor; tratant a m’artorno a la ment le paròle ‘d mè grand: “Lòn ch’it l’has ‘nt ël cheur a meuir mai!”
Gian dij Cordòla
LE PICCOLE COSE
Mio papà mi ripeteva sempre; “La nostra è una famiglia di contadini e anche tu sarai contadino.” Io no non ero contento! Da poco era finita la guerra e la vita in montagna mi sembrava troppo dura; io sognavo una vita più bella in città, quella città che le persone più anziane riferivano pregna di misteri: “Vedi laggiù al fondo della piana: Torino!” simbolo di un mondo raccontato da quei pochi viaggiatori che c’erano stati. Quando venne il momento di decidere non ho avuto esitazioni e mi sono andato alla stazione ferroviaria del paese. Prendo il biglietto per Torino e, aspettando il treno, la vita mi passa davanti veloce e tutta uguale. Un fischio e lo sbuffare della locomotiva a vapore mi distoglie dai pensieri.
Salgo e mi siedo su un sedile di legno vicino al finestrino attendendo trepidante il fischio del capo stazione. Con uno sferragliare di ruote, il treno si muove prima lentamente poi sempre più veloce. Io incollato al finestrino mi facevo rapire dallo spettacolo che avevo di fronte: i miei occhi vedono una danza di prati verdi intervallati da case e boschi, un fantastico scenario per me cresciuto in una piccola borgata di montagna tra rocce, pascoli e la sola compagnia delle mucche. Il rumore delle ruote sui binari concilia la mente ed aiuta ad isolarsi dal mondo; ma altri passeggeri salgono alle fermate successive e nell’aria si spande un odore di sigaro…
Finalmente arrivo in città. Fuori dalla stazione alzo gli occhi al cielo che non era più azzurro come lo vedevo in montagna, ma grigio; l‘aria era più pesante; le case sono alte più di quattro baite messe una sull’altra; le donne portano cappellini che sembrano nidi di merli e gli uomini, anziché la gerla portano una borsa: tutti camminano veloci senza parlare. Ma come è rumorosa la città pensai. Attraverso la strada ma uno scampanellio mi fa sobbalzare: è un tram, il primo che vedevo.
Sempre più teso giungo dall’altra parte della strada e vado verso una piazza piena di gente che si pigiava, che si urtava, che andava sgomitando; per terra cumuli di mercanzia di ogni genere, come alla fiera del paese. Questa piazza si chiama Porta Pila e qui si trova di tutto: dei calzoncini, delle gonne, degli zoccoli, ancora dei pomodori, del formaggio, del burro, dei polli, dei colombi e delle quaglie, anche stoviglie, trappole per topi e altri prodotti.
Una folla di donne, di serve, di contadini, estasiata si muove lentamente, sosta davanti alle merci, attratta anche dagli inviti dei venditori: “Venga avanti signora, bella merce a buon prezzo”. Frastornato mi avvicino per comprare qualcosa da mangiare, ma nelle tasche non ho più i pochi soldi avuti da papà, allora cammino senza una meta pensando tra me e me come ho potuto farmeli rubare o perderli.
Verso sera chiedo ad un vigile se ci fosse qualche fienile dove poter riposare. Questo, mi guarda stralunato come fossi matto e con un cenno mi indica una osteria. All’interno, l’aria è pesante e fumosa, vuoi per le troppe persone presenti, ma soprattutto per il fumo dei toscani e delle esalazioni del vino.
Alcuni cittadini, preso posto attorno ad un tavolo e ordinato un litro di quello buono si informano sulle novità della giornata. Altri, poco più in là, davanti un piccolo pubblico di attenti spettatori, si cimentano nel rumoroso gioco della morra, vietato ma sempre praticato.
L’oste, che domina sovrano questo via vai di gente d’ogni posizione sociale, è persona astuta e, appena capisce che sono senza denari, subito mi spinge alla porta. Così torno alla piazza del mercato; intanto che i venditori ritirano la merce, raccolgo a terra due mele bacate: sempre meglio di niente.
Mestamente, torno alla stazione ferroviaria; seduto nella sala d’aspetto mi sto appisolando, quando due uomini in divisa mi scuotono, e dopo aver controllato i documenti mi fanno uscire.
Basta, non ne posso più! Come mi manca la semplicità delle piccole cose di quella vita che credevo grigia, ed invece era la più bella. Ho voluto toccare con mano una nuova realtà, ed ho scoperto come ero felice nella mia borgata, con un bicchiere di vino alla cantina e le quattro chiacchiere con gli amici, cielo azzurro ed aria buona, in quella magica atmosfera di montagna.
Torno a casa a ritrovare le mie cose, piccole ma di grande valore; intanto mi tornano in mente le parole di mio nonno: “Quello che hai nel cuore non muore mai!”
Gianni Cordola
Premiato al concorso “Piemont ch’a scriv” edizione 2018 nella sezione narrativa breve in lingua piemontese.
Alcune immagini della premiazione