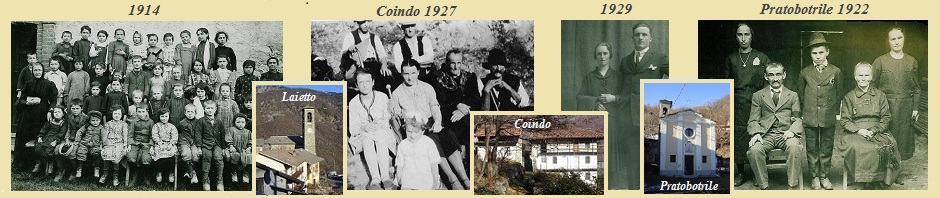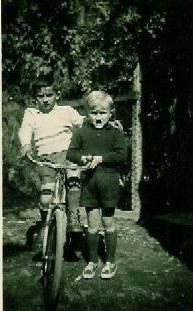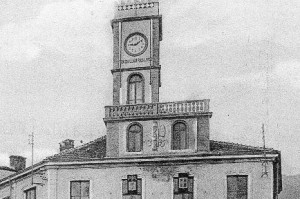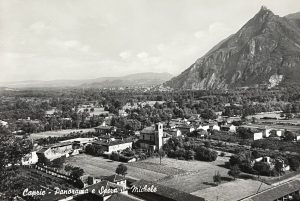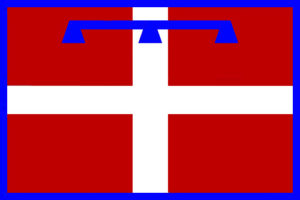Un articolo scritto da L. Vaccarone, tratto da: Rivista mensile del Club Alpino Italiano, Pubblicata per cura del consiglio direttivo – Redattore prof. Carlo Ratti – Vol. XII Anno 1893
La duchessa Jolanda, reggente e tutrice del figlio Filiberto I, trovandosi sullo scorcio dell’anno 1475 al castello di Rivoli, delibera di portarsi a Ginevra onde soccorrere il duca di Borgogna Carlo il Temerario, che fa guerra agli Svizzeri.
Emissari sono spediti nelle valli di Lanzo, di Susa, di Pinerolo a requisire bestie da soma pel trasporto del bagaglio ducale e della Corte. La piccola città di Rivoli è in fermento per i preparativi; gli alberghi San Giorgio, Scudo di Francia, Leone, Montone e Campana sono pieni zeppi di mulattieri, portatori e uomini d’arme. Un sergente è deputato a sorvegliare in Sant’Ambrogio il passaggio del bagaglio che s’incammina verso la metà di gennaio 1476. Occorrono duecento muli, e non sono troppi, come a tutta prima potrebbe parere, ove si consideri che nei suoi viaggi la Corte trasportava tutto con se, persino le tappezzerie “qui estoient demoureez tendues es murailles et chambre du chasteau de Riuolles quant madame se partist pour passer les montaignes du mont signix”.
Partito il bagaglio si pensa al corredo per le persone. La stagione rigida, proprio nel cuore dell’inverno, la tenera età dei principini, l’ultimo ancora con la nutrice, la dilicatezza delle dame, impongono degli accurati preparativi per difendersi dai gelidi venti della Vanoise. A riparare il capo si confezionano dei grandi cappucci di panno nero di Roan che scendono fin sulle spalle, foderati di velluto nero, a doppio pelo, dal collo in su e di pelliccia dal collo in giù. Dello stesso panno, foderati di pelliccia, si fanno pettorali. Il sarto prepara abiti “de fin drap gris daubeuille” per la duchessa e principesse, e “iaquetes de bon drap pour passer les montaignes” pei principini, foderati di penne bianche nel corpo e nelle maniche. I mantelli son di drappo bianco di Borgogna; la duchessa ne ha due, uno bianco guernito di 24 fibbie d’argento dorato, l’altro nero amplissimo in caso di gran freddo; calzature foderate dello stesso panno di Borgogna e guantoni di lana “fais a la gueulhe”.
II 12 febbraio la Corte si mette in viaggio. La duchessa Jolanda con le figlie, principesse Maria e Luisa, sono portate in lettiga; il duchino, d’anni 11, gli altri principini, dame e il seguito vanno parte in “charios branlans” e parte a cavallo. Vengono dietro 34 muli carichi di “viures vaysselle d’argent joyaulx tant de madame de monseigneur de mes damoyselles et des dames de la maison, reliques de la chappelle, toutes choses dangereuses, et aussi choses necessaires pour les officiers de panaterie cousine et boteillerie fait marche auecques culy”.
Dai conti di Tesoreria Generale di Savoia, conservati nell’Archivio di Stato in Torino e da cui ricaviamo le presenti notizie, non risulta che alcun cavaliere, all’infuori dello scudiere Ugonino di Montfalcon, accompagnasse la duchessa, o quanto meno non vi è nominato, mentre invece si nota con scrupolo il nome non solo delle dame ma pure delle loro cameriere . Le dame erano ventitre, nel conto specificate così: “madame myolans et sa fillie, la dame de Montchanuz, la dame de Troches, la dame de St ynocent, la dame de la Balme, la Ianne de Moussy, la Iaqueme de Challes, la Anthoynete de Villars, la guille de la moute, larthaude, la loyse dextre, la dame de la crois et sa fillie, la francoise mareschalle, la tomine de blonay, langloyse, la grecque, la verdonne, lysabeau de Beaulmont, la catheline, la marion”. Altrettante erano le cameriere.
Il primo giorno pernottarono ad Avigliana, il secondo a Susa. Ad ogni borgata si aggiungeva una scorta d’uomini del luogo che accompagnava il corteo sino alla borgata successiva, donde retrocedevano, sostituiti da un’altra scorta di quest’altro luogo. Nelle borgate in cui il corteo doveva fermarsi a pernottare giungevano precedentemente due camerieri ducali coll’incarico di “appareiller les giptes et les demourees auant que messeigneurs et dames arriuassent en leur logis”. A Susa si trovarono i muli venuti da Termignon per caricare le persone del seguito giunte sui carri; per i principini erano state costrutte ivi tre lettighe speciali.
Si parti il 14 da Susa. La duchessa e le principesse continuarono in lettiga sino alla Novalesa concedendolo lo stato della via, e così i principini i quali, perché non si annoiassero, separati com’erano l’un dall’altro, furono regalati ciascuno “dung ieu de cartes e dymy millier despingles pour passer temps en les dites lytieres”. Notiamo che a portare la lettiga della duchessa sono adibiti 16 uomini, così per quella del duchino Filiberto, pei principi Carlo e Giacomo Luigi 8 uomini. Le dame, cameriere ed altre persone del seguito sono sopra cavalcature tenute al morso ciascuna da un mulattiere.
Alla Novalesa aspettano le guide o marroni. La duchessa con le figlie, scese dalle lettighe, salgono su mansueti e robustissimi muli fatti venire da Lanslebourg, e si avviano verso la Ferrera con ai fianchi i marroni pronti ai soccorsi, essendo la strada, ripida ed angusta, sovrastante al profondo burrone della Cenischia. Questo passo, al pari di quello superiore detto delle Scale, era ed è tuttavia pericolosissimo nell’inverno, per l’effetto del gelo le cavalcature difficilmente possono reggersi e minacciano rovesciarsi ad ogni mossa di piede.
Abbiamo trovato in altro conto di Tesoreria Generale del 1375, un secolo prima della traversata di Jolanda, che nel trasportare il vasellame della Corte da Montmélian a Susa “ij vaissel se sunt perdu par deffaulte dune beste qui set derochie en moncenix desoubx la feriere en lesgue et la dicte beste fut morte”. Arrivati alla Ferrera si distribuiscono gli alloggi presso gli abitanti e le due “hosteleries du moton et de la croys blanche”.
Il viaggio non era stato funestato da alcun incidente, ma la marcia fu molto lenta causa le tre lettighe dei principini, troppo voluminose; e i marroni ebbero a dichiarare che con esse non si poteva fare la traversata. Fortunatamente nel corteo eravi il costruttore, Giovanni Monier maestro dei lavori del castello di Rivoli, il quale, aiutato da due garzoni, si mise subito attorno “en faire troys caysses pour pourte monseigneur le duc, charles monseigneur, et iacque loys monseigneur le prothonotaire”.
Per fare le tre grandi lettighe mastro Giovanni aveva lavorato dieci giorni a Susa, aiutato da altri falegnami della città, ed esse erano molto ben riuscite; a parte la mole non adatta per il luogo, non lasciavan nulla a desiderare, comode, eleganti, imbottite di panno della fabbrica di Pinerolo. Alla Ferrera invece le tre casse furono, si può dire, improvvisate. Si noti ancora che a un dato punto mancarono le ferramenta e i chiodi per fermare gli assi e si dovette spedire a cavallo l’oste del Montone a Susa per farne provvista.
Intanto mastro Giovanni, approfittando dell’assenza del padrone, mette sossopra l’albergo e vi prende quanto gli può servire; stacca dalle pareti ed applica alle casse delle lunge pertiche che facevan l’uffizio d’attaccapanni “pour pendre mantils linceulx et manteaux de pellerins”, raccoglie mazzi di corde “employe en estacher lesdites caysses pour les pourter en branle”, e tanto si agita e sospinge i lavori dei suoi aiutanti che al mattino seguente (15 febbraio) tutto è in pronto. Certo che in fatto di costruzione, di eleganza, saranno parse tre casse… da morto, ma di questo non si diede pensiero più che tanto mastro Giovanni, il suo obbiettivo era di fare, fare solidamente e presto, e l’ottenne.
La Corte parti dalla Ferrera montata sulle cavalcature, tranne i tre piccoli monsignori installati nelle casse, portate ciascuna da quattro uomini e seguite da altri quattro pel ricambio. Le cavalcature sono condotte a mano dai mulattieri, camminano ai lati della duchessa quattro marroni , le principesse ne han due ciascuna e le altre dame uno; altri quattordici sono destinati a portare aiuto ai muli pericolanti.
Il conto del Tesoriere Generale non fa menzione di alcuna spesa fattasi all’Ospizio del Moncenisio: probabilmente non vi si saranno fermati. Valicato il colle trovarono le slitte “pour ramassier”. Lo scudiere Ugonino di Montfalcon nota la retribuzione data a diversi bifolchi che da Lanslebourg han fatto trainare le medesime dai buoi sino al colle. Salirono nelle slitte la duchessa, il duca, le due principesse e altre dame “et sont alees despuis le dessus de la montaigne iusques bien pres de termignion”, nel qual paese pernottarono.
Il giorno seguente 16 ripartirono sui muli e raggiunsero St André ove si fermarono il 17 essendo giorno di domenica. Il 18 si portarono a St Jean-de-Maurienne. Madama de la Balme indispostasi non potè continuare il viaggio sul mulo, fu portata in lettiga da 16 uomini a St Jean-de- Maurienne indi a La Chambre ove rimase in cura verosimilmente in casa di parenti. Il 19 la Corte raggiunse Aiguebelle, il 20 Montmélian e il 21 Chambéry. II 22 i mulattieri, portatori e marroni di Lanslebourg, della Ferrera e Novalesa sono licenziati e fanno ritorno colle rispettive cavalcature ai loro paesi.
Ecco quanto abbiamo potuto ricavare dal conto del Tesoriere Generale, irto di cifre, diffuso, minuto nelle più piccole spese, ma assolutamente silenzioso su qualsiasi altro particolare non retribuito. I conti dei tesorieri, allora come oggi, non sono diari su cui sia permesso annotare descrizioni e impressioni di viaggio, ma viceversa, per quel che racchiudono, costituiscono una fonte sicura, di valore storico molto apprezzato. E però osiamo sperare che le cose sopra scritte siccome “vere” saranno gradite dagli studiosi quali granelli che giorno per giorno si raccolgono e vanno ad accrescere i materiali che dovranno un di servire per scrivere in modo esauriente la storia delle Alpi nei tempi andati.
L. VACCARONE (Sez. di Torino) Anno 1893