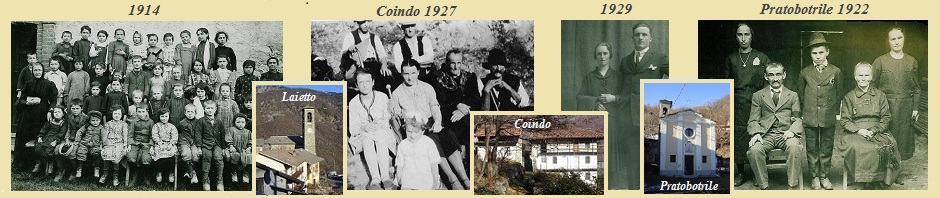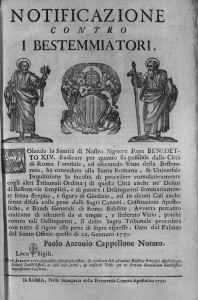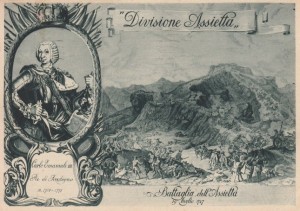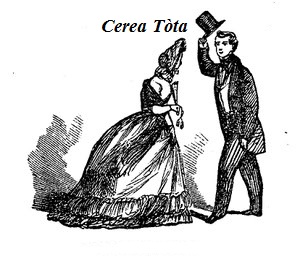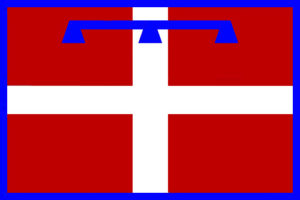Potremmo definire “bòja fàuss” come un’esclamazione di stretta origine piemontese, una specie di imprecazione, di stupore o di rabbia. Insomma dire “bòja fàuss” è come dire porca miseria, porco cane e altro di simile….non è da considerarsi una bestemmia o un imprecazione volgare, ma un modo carino e simpatico dei piemontesi per sottolineare un emozione o un episodio un po’ particolare. L’origine di tale esclamazione ha due diverse interpretazioni.
La prima sostiene che l’esclamazione sia nata come eufemismo, per evitare di bestemmiare il nome di Dio in tempi in cui era condannato il bestemmiare in pubblico, quindi si è sostituita una parola per convenienza o decenza e non incorrere nella trasgressione di leggi civili o notificazioni religiose. Con “bòja fàuss” si evitava di bestemmiare il nome di Dio proclamandolo falso e si spostava l’oggetto della maledizione dal nome di Dio a quello di una persona, o meglio di un mestiere, considerato spregevole da tutto il popolo, quello del boia. Stesso discorso vale per l’esclamazione “porca miseria”, non certo nata in concomitanza con un periodo di carestia, ma un’esclamazione nata per eufemismo, per evitare di bestemmiare il nome della Madonna (sostituito da “miseria”).
La seconda è più cara al Piemontese che impreca dicendo “bòia fàuss”, o si lamenta perché costretto ad andare “an sla forca”. Il boia per il piemontese è falso (fàuss) e se deve indicare un luogo lontano dice che è “sulla forca” (an sla forca) e questi due modi di dire hanno origini dalla storia popolare del Piemonte.
Tutto iniziò ai tempi delle esecuzioni capitali a Torino. Il luogo dove iniziò questa storia fu “ël rondò dla forca” il nome del quale, come facilmente comprensibile, deriva dal fatto che sino al 1853 vi si tenevano le pubbliche impiccagioni. In quel periodo temporale, l’attuale Rondò della Forca (in una carta di Torino del 1865 era chiamato Circolo di Valdocco) era un vasto slargo, che poteva quindi ospitare molti spettatori, circondato da grandi pini che rendevano l’ambiente sufficientemente buio e tetro. Tutto intorno prati, fossi, pozze e poche case. Il luogo fu scelto perché relativamente vicino alle carceri che a quei tempi erano nella attuale via Corte d’Appello. Le condanne a morte venivano eseguite mediante la forca, installata di volta in volta. Dopo un mesto tragitto dalle carceri, giungeva qui la carretta con il condannato, confortato da un sacerdote ed accompagnato da una scorta armata e dalla Confraternita della Misericordia.
In epoca napoleonica in piazza Carlina, che allora, ironia della sorte, si chiamava ancora “Place de la Liberté”, funzionava invece la ghigliottina, mentre i roghi e gli squartamenti avvenivano nelle piazze San Carlo e Castello. Bisogna dire che la pratica dell’impiccagione fu abolita dal ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Zanardelli nel 1889, ma che fino ad allora i Boia, pur essendo dei funzionari ufficialmente designati per eseguire le sentenze di morte dei condannati, non godevano della stima dei propri concittadini e , anche se ben pagati, facevano una vita solitaria e di scherno.
Il popolo non poteva accettare che il Boia guadagnasse denaro dall’uccisione di altri uomini, per questo i Torinesi lo battezzarono “Fàuss”. Al numero 2 di via Bonelli abitava Piero Pantoni, l’ultimo boia di Torino, diverse esecuzioni a carico e una moglie che per la vergogna non usciva mai di casa. La vicina chiesa di Sant’Agostino era detta la “chiesa del boia”, in quanto nei suoi pressi vi venivano sepolti i condannati a morte e i detenuti defunti in carcere.
Gian dij Cordòla